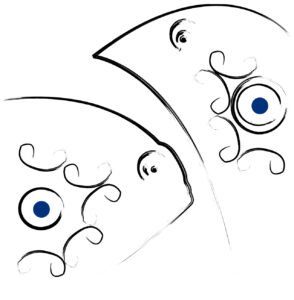Andrea Benetti, Dario Binetti: gli abissi della memoria
Ricordare. La maggiore dotazione cognitiva concessa al vivente, e insieme lo scarto che separa l’uomo dai suoi simili biologici. Non tanto nei meccanismi di acquisizione e di conservazione delle esperienze, caratteristici di quasi tutte le specie; quanto piuttosto nella capacità di esprimere i ricordi, e di esercitare la loro forza attraverso dei segni. Il difficile viaggio evolutivo della specie umana, dalle più remote forme dei preominidi fino alle attuali – apparentemente compiute – declinazioni del cosiddetto “sapiens”, è consistito essenzialmente in una progressiva appropriazione della memoria. Non è stato un percorso semplice, né lineare. Diversamente dalle altre cose, che trattengono una reminiscenza inerte nel loro progressivo dissolversi nel tempo, nello sfaldarsi della materia che si deteriora, l’uomo ha dovuto operare una azione di separazione tra sé e ciò che gli accadeva intorno. Per introiettare gli accadimenti, per fissare i loro contorni in immagini costantemente accessibili, ha dovuto affidare alla loro rappresentazione ciò che diversamente non sarebbe stato possibile conservare. Forse già da subito aveva compreso che nella mente lavorano due tendenze antagoniste: quella che fissa i pensieri e li tiene accesi, e quella che tende a cancellarli. Non del tutto, naturalmente, poiché le loro tracce restano indelebili e si sedimentano in un coacervo di frammenti di consapevolezza, in pallide larve che riemergeranno – chissà quando, chissà dove – anche a distanza di generazioni e senza che sia possibile ritrovarne l’origine. Le più antiche pitture rupestri, le incisioni astratte o realistiche che solcano le pareti di innumerevoli grotte in tutto il mondo avevano quasi certamente la funzione di dispositivi mnemonici: strumenti visivi per custodire il tempo, per fermare le idee continuamente cangianti, per ricordare il futuro. Preservare la memoria significava per quegli umani in costante pericolo rendere propizia persino la paura, addomesticare l’ignoto, vedere al di là di ciò che fosse immediatamente percepibile. Le immagini aiutano a capire, e sono esse stessa conoscenza.
L’opera pittorica di Andrea Benetti, ormai da più decenni, ha inteso ripercorrere le orme di antichissimi maestri senza nome, e riportare l’arte alla sua originaria essenza di meccanismo di memoria: una espressione spirituale dell’essere, emotivamente spontanea, libera dalle costrizioni della forma mimetica. Le rappresentazioni sono una proiezione della mente estesa al di fuori del sé, la necessità incontenibile di plasmare il mondo per renderlo comprensibile e più facilmente dominabile. L’artista sin dalle prime prove si è immedesimato nel desiderio creativo dei primi uomini, nel loro bisogno di lasciare delle tracce che parlassero innanzitutto a loro stessi, e che esorcizzassero i loro timori. Benetti non si è accontentato di declinare un primitivismo ormai da più di un secolo acclimatato nell’arte occidentale. Imitare forme che appartenevano a epoche ignote gli è parso banalizzare messaggi che si sarebbero tradotti una sterile e anacronistica riproposizione di un mondo inconciliabile con il presente. Così ha sperimentato tecniche e materiali archetipici, pigmenti naturali di immemorabile origine, nell’idea che l’arte non sia altro dalla natura, ma essa stessa prodotto della terra e che all’uomo spetti solo assecondare il suo impulso creativo.
Il sodalizio con Dario Binetti forse era iscritto persino nella quasi esatta omofonia dei loro nomi e nella loro identità anagrafica. L’artista salentino, in un modo diverso, ha seguito un percorso parallelo a quello dell’amico emiliano. In un tempo in cui la fotografia ha inseguito il vorticoso processo di innovazione tecnica per arrivare, in uno con la definizione sempre più lenticolare dell’immagine, alla totale smaterializzazione del prodotto, Binetti ha voluto tornare alle origini della rappresentazione fotografica. L’uso della camera oscura e del bianco e nero, i tempi di posa talora lunghissimi, gli hanno da sempre consentito una resa della realtà che non è la semplice e meccanica riproduzione del visibile. I luoghi osservati dall’occhio e dalla camera oscura di Binetti si caricano di un’atmosfera numinosa, registrano presenze ineffabili, restituiscono un mondo che il più tecnologicamente avanzato strumento fotografico non riuscirebbe a cogliere. Se nella resa della figura umana, in pose plastiche che sottraggono all’oscurità alcune evidenze corporee, Binetti guarda possibilmente a Robert Mapplethorpe e alla sua capacità di afferrare l’essenza spirituale dei personaggi nella loro epifania anatomica, nel rievocare i luoghi ritorna alle origini della fotografia, e a quel movimento che affidava alla macchina fotografica il ruolo di medium con la dimensione dell’altro. Antichi edifici, ipogei immersi nell’ombra, corridoi dai muri cadenti offrono al suo obbiettivo le immagini invisibili di ciò di cui si sono intrisi nel tempo.
Con la collezione “Luce nel silenzio” Benetti e Binetti hanno rivoluzionato la tecnica rappresentativa e la capacità stessa delle forme di offrirsi ai viventi. Già il nome della raccolta evoca un rovesciamento della tradizionale funzione commemorativa delle immagini: gli abissi rupestri delle Grotte di Castellana si danno come una dimensione primigenia dell’esistenza, l’epoca nella quale il processo della creazione sembra di là dal cominciare, e tutto è indistinto in un reticolo di venature pietrificate. Le tenebre divengono l’inghiottitoio delle esperienze, e l’assenza del tempo è nello stesso istante l’inesistenza della memoria. La natura, in questo luogo che evoca gli inizi di tutte le cose, sembra non avere ancora iniziato la sua metamorfosi. L’antro è lo spazio dell’unità primordiale, il posto in cui coscienza e conoscenza non sono ancora separate, esattamente come nel mito platonico. Nella Repubblica la caverna è un luogo protetto: vi regna sì l’illusione che le ombre che si proiettano sulle sue pareti siano una effettiva realtà, e l’impossibilità a muoversi dei prigionieri che vi stanno rinchiusi è un sintomo del loro stato di minorità e di schiavitù. È però da quello stato primordiale che devono prendere avvio le cose per diversificarsi da quel caos indeterminato.
Qui i due artisti hanno trovato lo scenario per un nuovo, sorprendente esperimento tecnico e rappresentativo. Le scene sembrano evocare i quadri di un romanzo gotico, silenziosamente popolate da figure incappucciate che partecipano a un misterioso rito iniziatico. Ovunque aleggia la dimensione estetica del Sublime, inteso nella sua accezione più autenticamente intrinseca alla sensibilità moderna: sortiscono da quelle profondità l’enigma, la grandezza incommensurabile, i contrasti tra luce e buio, il silenzio e il riverbero delle ombre. Poche volte, come in questo caso, la capacità tecnica dell’artista e l’intelligenza visiva del fotografo hanno raggiunto effetti così suggestivi: le fotografie richiamano a una profondità illusoria, che però è del tutto reale grazie alla superficie in bassorilievo approntata su cui sono stampati gli scatti.
La mostra di Ascoli Piceno segna il punto più alto del percorso creativo di Andrea Benetti e Dario Binetti, poiché giunge a una riflessione finora definitiva (eppure, non ancora conclusa) sul potere emotivo delle immagini, sul loro destino e sul dualismo tra memoria e oblio: i temi che sono la sostanza stessa del nostro essere al mondo.
Prof. Paolo Francesco Campione |
Docente di Storia dell’Arte e Museologia e Storia del Collezionismo |
Università degli Studi di Messina |