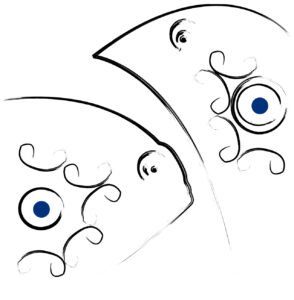Creazione e desiderio. L’arte delle origini di Andrea Benetti
Il primo uomo che tracciò su una parete un segno intenzionale, o vi lasciò la sagoma della propria mano come se fosse la proiezione di un’ombra, cambiò per sempre le sorti della propria specie. Quella linea, incisa piuttosto che pitturata, quell’impronta in positivo o in negativo, segnavano uno scarto irreversibile rispetto all’agire del resto dei viventi e lo ponevano – per restarvi definitivamente – al sommo di una gerarchia il cui ruolo di comando sarebbe stato molto semplice da definire, eppure infinitamente complesso nei suoi sviluppi: l’umano si staccava dagli altri esseri per essere capace di riprodurre in immagini, di plasmare in forma concreta, ciò che vedeva. Più brevemente: di elaborare simboli. Forse non era un ambiente del tutto ospitale, quantunque incorrotto, quello di quei primi esperimenti artistici. Il mondo attorno all’uomo era in costante trasformazione, ovunque s’annidavano pericoli e misteri, meraviglie e orrori: la natura stessa aveva le vesti di una insaziabile predatrice, determinata a contendere a quell’animale più evoluto rispetto agli altri gli spazi della vita. Eppure proprio nel rappresentare la natura quell’essere trovò lo strumento vincente a governarla, a comprenderne le minacce ed esorcizzare le paure di quella sfida incessante. Non era certamente l’essere più forte che avesse elaborato la biologia, ma rispetto a tutti gli altri individui aveva maturato una risorsa del tutto peculiare, e che si sarebbe rivelata potentissima: l’uomo raccoglieva rappresentazioni poiché aveva intuito che il filtro dell’arte rendeva il mondo più facilmente comprensibile, e perciò dominabile. Forse lo sviluppo dell’intelligenza e il raffinamento delle facoltà cognitive permisero ai primi uomini di divenire i capostipiti di una genia di artefici; o forse, più suggestivamente, l’esercizio dell’arte provvide a rafforzare la loro intelligenza, a rendere più complesso e significante il loro linguaggio; forse entrambe le cose sinergicamente: nessun’altra creatura seppe sviluppare il duplice sistema comunicativo della voce e dell’immagine, di qualcosa che – allo stesso tempo – era il sé e l’altro da sé. Nella grotta dell’isola di Maros a Sulawesi, che ha restituito reperti risalenti a più o meno quarantamila anni fa, le sagome tracciate sulle parerti – realizzate usando le mani come specie di stencil – paiono una radiografia di braccia sottili e aggraziate, di dita affusolate: quell’antichissimo artista era forse una donna e a quel gesto che pare simile a una (ap)prensione forse aveva affidato la volontà di assumere il dominio di quei luoghi, di fissarne la proprietà attraverso un segno che fosse – allo stesso tempo – una sorta di autoritratto simbolico, o un’autentica sineddoche corporea: la mano, capace diversamente dalle zampe di molti altri animali di afferrare gli oggetti e di tenerli con cura, di trasformare la materia, era lo strumento più tecnologico cui fosse giunto il percorso evolutivo delle specie viventi nell’arco di milioni di anni. A La Pasiega in Cantabria la storia dell’arte risale ancora più indietro nel tempo, e salta fino ai Neanderthal di sessantacinquemila anni fa. Quegli umani arcaici non avevano le forme snelle dei moderni: la loro fronte sfuggente e le aggettanti ossa sopracciliari atte a sorreggere i muscoli della masticazione di poderose mascelle, la corporatura massiccia parevano progettate più per il combattimento che per la creazione e la contemplazione estetica. Eppure quegli esseri avevano sviluppato un pensiero astratto molto complesso, in grado di simbolizzare la realtà intorno e di tradurla in immagini dipinte. Forse non sapevano cosa fosse la bellezza, eppure erano in grado di darle vita attraverso le loro creazioni. Erano stati capaci di proiettare la propria mente su una parete, di fissarvi desideri e paure: proprio qui a La Pasiega le rappresentazioni (in realtà non troppo stilizzate, anzi persino realistiche) di bovidi stanno dentro una figura a forma di scala che probabilmente è un primitivo recinto entro cui custodire gli animali. Parrebbe la prima icnografia della storia, l’antesignana di una pianta o di una mappa: forse avevano elaborato un qualche senso del possesso, o forse avevano imparato che per meglio conoscere il mondo bisogna farsene un’immagine stabile. Di più: ripetendo l’azione di raffigurare, raccogliendo immagini su immagini talora sovrapposte come autentici palinsesti iconici, erano finanche divenuti dei progenitori dei collezionisti. Le pareti delle grotte di luoghi distantissimi tra loro, eppure accomunate dal medesimo fenomeno decorativo, cominciarono a divenire delle specie di pinacoteche nelle quali l’immaginario di quelle comunità si rispecchiava come in un perenne desiderio di benessere fisico e mentale. Probabilmente era una incoativa forma di religiosità a ispirare il loro fare artistico, e tuttavia quei luoghi ornati da pitture e graffiti davano vita a un mondo rassicurante, al cui sommo – come una divinità creatrice – stava l’uomo. Ecco perciò la svolta dell’umano, capace da sé di costruirsi una struttura mentale performativa: fare aiutava a essere e nel fare con sempre più efficace perizia l’intelligenza si consolidava, ed era capace a sua volta di ascendere nuovi gradi di difficoltà. Sarebbe errato credere che la vera conquista dell’arte sia stata solo la somiglianza tra il reale e l’artefatto, la sempre più stretta aderenza fra la rappresentazione e il modello. A fronte di immagini mano a mano più complesse e persino “virtuali” (nei graffiti della Grotta dell’Addaura presso Palermo, risalenti a circa quattordicimila anni fa, gli autori avevano già sperimentato le regole della prospettiva e del proporzionamento delle figure in ragione della distanza dal primo piano), gli antichi artisti elaborarono senza sosta un sistema di figure aniconiche o di esseri che non trovavano riscontro nel mondo dell’esperienza. Da una parte stava perciò l’inesauribile desiderio di riprodurre ciò che stava intorno all’artista, in un continuo osservare e rendere; dall’altra l’istanza di dar vita a una realtà interiore infinitamente più grande, nella quale i vincoli della natura o erano più labili o addirittura non esistevano affatto. Fare arte non generava solo una mente logica più plastica, né solamente sviluppava capacità organizzative dello spazio fondamentali al di là dell’arte stessa. Generare immagini aiutava a sua volta a “immaginare”, e allargava sempre più quell’orizzonte della fantasia che sarebbe stato l’inestinguibile giacimento della creatività. Nei millenni l’arte avrebbe proseguito lungo la strada del realismo, oscillando di volta in volta tra una rappresentazione migliorativa del dato e una sua degradazione verso le forme del brutto. Ogni cosa tuttavia, sia che della vita desse un’immagine incantata e rassicurante, sia che esplorasse le regioni dell’incubo e dell’orrore, nella creazione artistica si sarebbe ricomposta in un risultato bello. È vero, sempre più l’arte si sarebbe avviata a divenire strumento del potere, mezzo di propaganda, e sempre più a misura del suo essere uno specchio fedele della realtà. Non s’è mai data infatti un’arte “di regime” che non fosse al tempo stesso un’immagine perspicua di ciò che rappresentava, un duplicato del mondo. Eppure la fantasia prorompente dei primi artisti della storia è rimasta perennemente incorrotta, e vitale come un magma sotto i ghiacci. Quando l’arte tornò svincolata dalla sua necessità di celebrare sovrani e mecenati, molti artisti si volsero alle origini dell’espressione: il che significava, semplicemente, liberare quella potenza creatrice che per millenni era stata tenuta nascosta a esclusivo vantaggio del figurativo. Quando Carl Einstein nel 1915 pubblicava La scultura negra, Picasso aveva già da qualche tempo completato Les demoiselles d’Avignon: quasi un manifesto di un’arte che ora guardava non solo verso un passato lontanissimo, ma anche verso le culture di luoghi che l’eurocentrismo aveva preteso negli ultimi secoli ridurre in subalternità. Se i grandi maestri della storia dell’arte erano destinati a riposare per sempre in una specie di inaccessibile empireo, da cui non sarebbero più stati destati da pedanti e tormentosi imitatori, adesso erano gli artisti senza nome dei millenni trascorsi a tornare con la forza prorompente della loro fantasia. L’essenza più viva della creatività non stava più nelle cattedrali, nei grandi palazzi, nei musei sonnolenti: stava piuttosto ad Altamira o a Lascaux, a Levanzo o a Laas Gall in Somalia. In tutti quei siti rupestri sparsi in ogni angolo del mondo nei quali l’uomo, rappresentando la realtà o dando adito all’immaginazione, aveva creato se stesso. L’arte delle origini di Andrea Benetti giunge così alla fine dell’arte. E non si è forse tanto distanti dal credere che quella sia anche la fine della storia. Vi arriva però con un progetto di speranza, in un mondo che la speranza (e con essa l’umanità, l’identità, la curiosità) l’ha sepolte da tempo. Quando nel dicembre del 2006 pubblicava il proprio manifesto dell’arte Neorupestre l’artista era ben lontano dal credere che le sue parole sarebbero state persino più attuali quasi vent’anni dopo. Ravvisava l’urgenza di tornare a una autenticità più profonda, a un più vivo senso della bellezza, a una stima del valore delle cose che non fosse dettata dalla cupidigia forsennata del guadagno. Sbaglierebbe chi credesse che le parole, pur sinistramente profetiche dell’artista, postulassero il ritorno a una incorrotta età dell’oro. Il passato non torna, fortunatamente, e ogni tentativo di fuga all’indietro si è sempre tradotto in una catastrofe. Semmai il messaggio di Andrea Benetti andava allora e va oggi esattamente in una direzione opposta: costruiamo un futuro diverso a partire dall’esempio di chi quel futuro, migliaia di anni fa, lo creò con la forza incoercibile dell’immaginazione, con il rispetto dell’ambiente, con l’entusiasmo delle idee. Con mezzi di fortuna, con i materiali che approntava la natura e gli strumenti che essi stessi preparavano, gli antichi avevano già immaginato tutto. Ogni elaborazione giunta successivamente, illusoriamente progressiva, sarebbe stata solo una pallida copia. Da qui le sperimentazioni “sostenibili” dell’artista, l’uso di pigmenti naturali – talora persino tratti dalla nostra alimentazione quotidiana – ispirati all’agire dei primi pittori della storia. Quel repertorio di figure e forme plastiche, di geometrie archetipiche, si arricchisce di cromie accese e raffinate: la tecnica di Andrea Benetti ripercorre il sogno creativo dei millenni trascorsi, non senza una qualche suggestione da grandi artisti del Novecento che – a loro volta – hanno guardato alle origini dell’arte: Wassily Kandinskij, Mark Rothko, Joan Mirò, Paul Klee. La mostra di Palazzo Zaguri giunge al compimento di un percorso creativo lungo il quale l’artista ha, opera dopo opera, costruito la propria immagine di Venezia. Nelle linee gotiche e bizzarre dei palazzi, nell’andamento sinuoso dei suoi canali pareva già iscritto il codice genetico e segnico della sua arte: bastava solo dar forma a quel desiderio. Quel sogno prende corpo nelle diciassette opere esposte, altrettante visioni di un mondo interno e incantato nel quale la creatività degli antichi – come in un eterno presente – non si è mai esaurita. E forse essa stessa è l’antidoto al male del presente.
Prof. Paolo Francesco Campione |
Docente di Storia dell’Arte e Museologia e Storia del Collezionismo |
Università degli Studi di Messina |